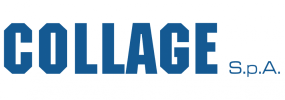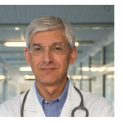La piastrinopenia immune primaria (ITP) si può considerare globalmente una patologia ematologica relativamente rara, con una stima approssimativa della sua prevalenza nella popolazione adulta tra 5 e 10 casi ogni 100.000 soggetti. La ITP negli ultimi anni ha ritrovato nel mondo scientifico un rinnovato interesse scientifico e clinico per la disponibilità di nuove terapie che hanno sollecitato a valutare sempre con più attenzione le varie opzioni. Si conferma che la terapia di I linea è rappresentata dal corticosteroide a dosi elevate che trova uso nei pazienti sintomatici o comunque con un numero di piastrine inferiori alle 20.000/mmc. Il suddetto trattamento comunque permette di ottenere una risposta duratura solo nel 20-30% dei casi, a fronte dei possibili effetti collaterali di varia natura e per altro non trascurabili a carico di vari organi ed apparati. La splenectomia ancora oggi è considerata una valida opportunità terapeutica permettendo di ottenere una risposta duratura nei livelli di piastrine nei due terzi dei casi. Tuttavia tale procedura è sempre meno impiegata, per la disponibilità di nuovi farmaci avvenuta negli ultimi 10-15 anni, in particolare il Mabthera (anticorpo anti CD20) e gli agonisti del recettore per la trombopoietina (TPO-RA) Romiplostim ed Eltrombopag. Situazioni che ancora oggi impegnano i clinici riguardano circa il 10-15% dei pazienti con ITP che si dimostrano refrattari a più linee terapeutiche e che pertanto hanno necessità di un trattamento cronico con morbilità e mortalità che in alcune casistiche raggiunge il 10-15%, con la persistenza di un elevato rischio emorragico e la presenza di effetti collaterali dovuti alle varie terapie impiegate.
In questo senso ancora nel 2019 rimangono aperti vari quesiti quali la scelta e la sequenza delle varie opzio
OBIETTIVO FORMATIVO
A questo proposito, riteniamo importante proseguire in quel progetto di messa a confronto e in comune delle esperienze delle numerose ematologie della regione Emilia-Romagna, al fine di tracciare e definire dei percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, assicurando anche la messa a comune di informazioni utili per la stessa comunità scientifica.
ni terapeutiche, a quale paziente somministrare i vari farmaci, o quando procedere con la splenectomia, tutti punti che sollecitano un vivace dibattito scientifico che attualmente sta animando l’ambiente ematologico.